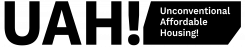Porto Fluviale Rec House
L’occupazione abitativa di Porto Fluviale, avviata nel 2003 nel quartiere Ostiense, è una delle più longeve di Roma, riuscendo a far coabitare culture diverse e offrire spazi e servizi aperti al quartiere. Nel 2020, il Comune di Roma ha avviato una co-progettazione con l’Università Roma Tre e la comunità occupante per trasformare l’ex caserma in un modello di edilizia sociale e rigenerazione urbana. Il progetto “Porto Fluviale RecHouse”, vincitore del bando PINQuA e finanziato dal PNRR, ha dato il via ai lavori nel 2024. L’intervento mira a rifunzionalizzare l’area senza consumo di suolo, integrando efficienza energetica, edilizia sociale e spazi condivisi. Grazie a una gestione partecipata, Porto Fluviale RecHouse diventerà un modello di coabitazione sostenibile e inclusiva, preservando la continuità storica dell’occupazione.

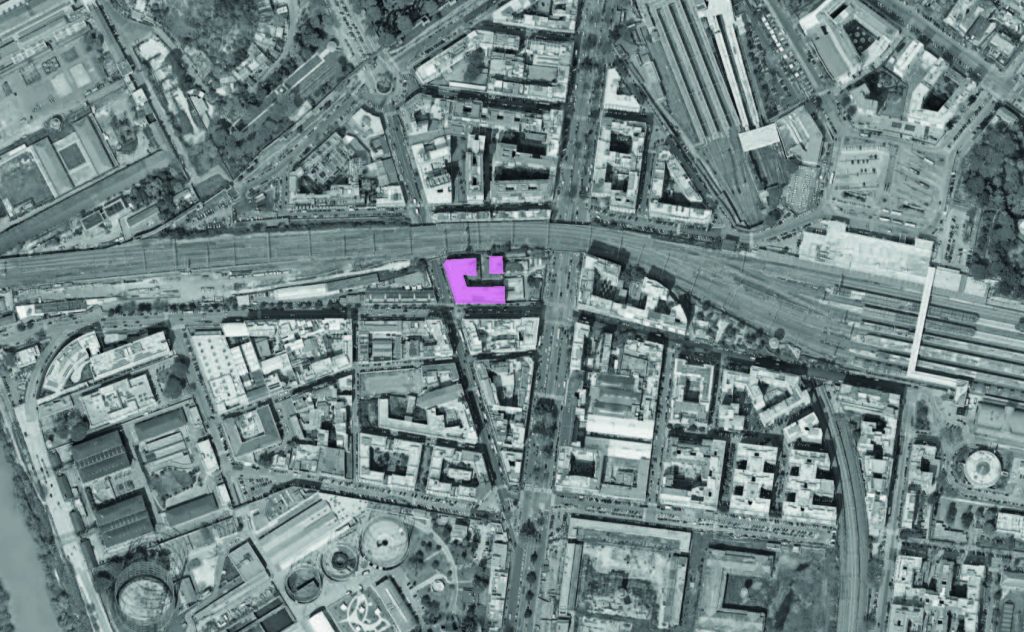
Keywords
LINK
Categorie di intervento
Progettisti
Ente promotore
Cronologia
2003: occupazione dell’edificio
2021: inizio del processo di istituzionalizzazione
2021-2026: cantiere
Budget
Obiettivi
L’obiettivo è recuperare un bene vincolato attraverso la rifunzionalizzazione di un immobile dismesso, evitando il consumo di nuovo suolo e adottando un approccio improntato alla sostenibilità e alla densificazione urbana. Il progetto prevede interventi di efficientamento energetico, garantendo prestazioni elevate in termini di risparmio e riduzione dell’impatto ambientale. Parallelamente, l’iniziativa punta ad ampliare il patrimonio di edilizia sociale, offrendo soluzioni abitative accessibili e contribuendo alla riduzione del disagio abitativo. Ciò avverrà attraverso un processo di integrazione sociale che favorisca l’inclusione e la coesione tra i residenti, mitigando le criticità legate all’occupazione abitativa e promuovendo modelli di convivenza sostenibili. Un altro aspetto centrale del progetto è la creazione di nuovi spazi pubblici, restituendo alla comunità aree di aggregazione e servizi condivisi. L’intervento sarà supportato da modalità innovative di gestione.
Non convenzionalità
Abbordabilità
Gli alloggi saranno assegnati agli attuali abitanti con un canone di edilizia residenziale pubblica (ERP), una forma di canone sociale calcolato in base alla condizione economica del nucleo familiare.
Informalità
Il progetto ha origine da un’esperienza di occupazione abitativa promossa dai movimenti per la lotta per la casa di Roma, sviluppatasi attraverso un’occupazione durata 20 anni.
SCHEDA INFORMATIVA
CARATTERISTICHE PATRIMONIALI
Regime d'uso
Tipo di intervento
Soggetti attuatori
Distribuzione territoriale
Soluzione abitativa
Integrazione con spazi ad uso non residenziale
Servizi condivisi
Unità individuali
Unità permanenti
Proprietà
Dati spaziali
Numero di edifici
Tipologia edificio
Piani per edificio
Numero di unità abitative
Superficie totale
Spazi privati
Spazi condivisi
Spazi collettivi
Spazi pubblici
Accesso all'edificio
Distribuzione abitazioni
Soluzioni spaziali
Tipologia unità
Superficie unità
Distribuzione unità
Zona notte/individuale
Zona giorno/comune
Altezza interpiano
Soluzioni spaziali unità abitative
BENEFICIARI E PROCESSO
Numero beneficiari
Tipologia beneficiari
Usi non residenziali
giardino fotovoltaico su terrazza comune; servizi di vario genere verranno aperti a tutta la città nel cortile: un mercato a km 0, uno sportello antiviolenza, usi civici e collettivi intergenerazionali e tecnologico-digitali per didattica a distanza e trasferimento tecnologico, spazi per l’artigianato, per l’allenamento circense e la danza, una sala da tè e un centro di mobilità sostenibile
Modalità di gestione
giardino fotovoltaico su terrazza comune; servizi di vario genere verranno aperti a tutta la città nel cortile: un mercato a km 0, uno sportello antiviolenza, usi civici e collettivi intergenerazionali e tecnologico-digitali per didattica a distanza e trasferimento tecnologico, spazi per l’artigianato, per l’allenamento circense e la danza, una sala da tè e un centro di mobilità sostenibile
Modalità di accesso
Gli alloggi saranno assegnati attraverso un bando di edilizia residenziale pubblica (ERP) speciale (gli attuali assegnatari sono gli ex-occupanti, i quali hanno goduto di una specifica priorità nell’assegnazione dell’alloggio).
Testi e scheda a cura di Constanze Wolfgring e Sofia Rizzo. Elaborazioni grafiche di Sofia Rizzo: le riletture critiche si basano sull’interpretazione dell’autore del caso di studio sopra riportato.